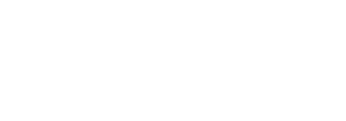Aggiornamenti
NOTIZIE E SENTENZE
Sulla valenza del rifiuto del datore di lavoro a ricercare accomodamenti ragionevoli ai fini della valutazione della ricorrenza della buona fede nell’inadempimento del lavoratore rilevante ai sensi dell’art. 1460 c.c.
La giurisprudenza relativa ai ragionevoli accomodamenti prosegue nella definizione sempre più compiuta della fattispecie, contribuendo ad arginare la vaghezza della relativa nozione. Una nozione introdotta nel nostro ordinamento solo a seguito della condanna dell’Italia da parte della Corte di Giustizia UE per il mancato corretto recepimento della direttiva 2000/78/CE, nella parte in cui prevede l’obbligo degli accomodamenti ragionevoli (CGUE, 4 luglio 2013, C-312/11, Commissione Europea contro Repubblica Italiana) a cui è conseguita l’introduzione del comma 3- bis dell’art. 3 d.lgs. n. 216/2003.
La disciplina originaria, pacificamente, presentava alcuni limiti significativi: da un lato, la genericità della definizione degli accomodamenti ragionevoli; dall’altro, l’assenza di procedure chiare per la richiesta e l'atttuazione di tali misure.
Recentemente, nozione e procedure sono state ridefinite ad opera del d.lgs. 3 maggio 2024 n. 62, ma è la Cassazione, nella sua funzione nomofilattica, che continua a fornire un contributo fondamentale allo sviluppo dei relativi concetti e, come spesso accade, a colmare le lacune normative.
Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ribadisce, in maniera quanto mai precisa e (verrebbe da dire) definitiva, la misura entro la quale i ragionevoli accomodamenti vincolano il datore di lavoro ad adottare condotte concrete volte ad eliminare (o limitare al massimo) le barriere di diversa natura che ostacolano la piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità alla vita professionale, su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.
Il caso di specie: la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva accertato la legittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore difeso da Legalilavoro Napoli per protratta assenza ingiustificata dalla sede di ultima assegnazione, posta a centinaia di chilometri dal luogo di residenza. La Corte affermava che anche laddove il lavoratore - malato oncologico riconosciuto invalido al 100% e portatore di handicap in situazione di gravità - potesse vantare un diritto all’assegnazione di una sede diversa rispetto a quella di sua originaria adibizione, ciò non sarebbe sufficiente a soddisfare i presupposti dell’eccezione di inadempimento dallo stesso invocata a giustificazione del rifiuto della prestazione. Nonostante che, nelle more, si fosse effettivamente liberato un posto di lavoro presso una sede posta in prossimità della sua abitazione.
Secondo la Corte di appello «a prescindere dalla valutazione di sussistenza o meno di una possibilità che la [società] adottasse ragionevoli accomodamenti funzionali al miglior impiego del [lavoratore] in considerazione delle sue patologie e limitazioni, non è da quest’ultimo dimostrato – ed è solo genericamente allegato – che le condizioni di salute gli impedissero la ripresa del lavoro nella sede di sua occupazione prima dell’inizio della malattia». Tale assunto trova la ferma censura della Cassazione, che lo ritiene non conforme allo statuto di speciale protezione che l’ordinamento interno e comunitario stabilisce per le persone con disabilità.
La stessa Convenzione ONU del 2006 sui diritti delle persone con disabilità, all’art. 2, definisce «discriminazione fondata sulla disabilità qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo». Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole; dove, per "accomodamento ragionevole", intende «le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali».
In ambito comunitario, poi, la direttiva 2000/78/CE, all’art. 5 dedicato alle «soluzioni ragionevoli per i disabili», statuisce che «per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti
appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere
finanziario sproporzionato».
Tanto premesso secondo la Cassazione (ed in accoglimento di uno specifico motivo di ricorso), nell’applicare quanto disposto dall’art. 1460, 2° comma, c.c. - alla stregua del quale il lavoratore può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, non risulti contrario a buona fede – la Corte di Appello avrebbe dovuto tenere in adeguato conto l’entità dell’inadempimento datoriale. Entità che deve essere valutata in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto e la concreta incidenza del detto inadempimento datoriale su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore, dando, in tal modo, seguito a precedenti pronunce intervenute sul punto (ad es. Cass. 4404/2022 e Cass. 11408/2018).
Ha errato, dunque, la Corte di Appello a "prescindere" (sic) dalla consistenza dell’obbligo di accomodamenti ragionevoli gravanti sul datore di lavoro nei confronti di un dipendente disabile. E la Cassazione chiosa, in maniera che verrebbe da definire perentoria: «il rifiuto di accomodamento ragionevole costituisce atto discriminatorio, come tale affetto da nullità, di cui certo il datore di lavoro non può trarre vantaggio in alcun modo; solo in tale contesto la Corte bolognese avrebbe dovuto valutare l’entità dell’inadempimento della società e verificare se il rifiuto opposto dal dipendente fosse o meno contrario a buona fede».
In tal modo, a parere di chi scrive, la Suprema Corte coglie l’essenza vera della condotta (assolutamente antigiuridica) del datore di lavoro nel caso di specie: ignorare clamorosamente un diritto posto dalla normativa nazionale e sovranazionale per poi utilizzare tale (propria) voluta omissione al fine di giustificare un licenziamento.
Con la pronuncia in commento, conclusivamente, la Cassazione (aderendo a un orientamento già formatosi) pare voler porre un argine alla disinvoltura con la quale alcuni datori di lavoro (specie quelli concretantisi in soggetti di maggiori dimensioni) spesso ignorano precetti posti da norme a carattere sovranazionale, probabilmente ancora non metabolizzate in maniera compiuta dall’ordinamento interno.
Ora sarà la Corte di appello di Firenze (giudice del rinvio), in applicazione dei principi innanzi cennati, a dover effettuare in maniera più aderente al complesso normativo nazionale ed eurounitario quel raffronto tra gli opposti inadempimenti che la corte felsinea ha omesso di considerare.
a cura di Luca De Simone
Legalilavoro Napoli
(Cass. 21 novembre 2024 n. 30080)
Parole chiave: disabilità , Discriminazione , Lavoro e salute , Licenziamenti , persone e dignità